
Raccontare Ascoltare Comprendere
Barbara Poggio - Orazio Maria Valastro (sous la direction de)
M@gm@ vol.10 n.1 Janvier-Avril 2012
PSICHIATRIA, RESTITUZIONE E SUBLIMAZIONE DEL ‘MALE’ NELLE PAROLE DEI PAZIENTI PSICHIATRICI
Vincenza Pellegrino
vincenza.pellegrino@unipr.it
Dipartimento Studi Politici e Sociali – Università di Parma e
Laboratorio Interdisciplinare Scuola Internazionale Superiore Studi Avanzati
(S.I.S.S.A.) – Trieste. Dopo un dottorato di ricerca in Antropologia Demografica
presso l’Université de la Méditerranée di Marsiglia e lunghi studi post-dottorali
compiuti tra Svizzera, Francia e Marocco, dedicati alle reti migratorie
e alle migrazioni transnazionali, oggi lavora come ricercatrice nell’ambito
della sociologia dei processi culturali con particolare interesse per
la trasformazione delle istituzioni e delle relazioni di cura, e nell’ambito
della sociologia della scienza con particolare interesse per la relazione
tra scienza e politica nei conflitti attuali e nelle nuove forme della
partecipazione civico-politica.
1. Storia e impostazione metodologica dell’indagine
a) L’incontro intervistati – intervistatori è di per sé cosa difficile,
se poi l’intervistatrice è una tipa impressionabile...
Perché il “patto narrativo” va ben preparato.
Il presente saggio è centrato sulle storie di vita (più specificamente
potremmo dire sulle storie di malattia e di cura) di pazienti psichiatrici
di Trieste raccolte ormai anni or sono (a partire dal 2005) su desiderio
di Peppe Dell’Acqua, direttore del dipartimento di salute mentale di Trieste
e discepolo di Basaglia, intenzionato a costruire un “archivio” delle
memorie di pazienti a lungo presenti nel suo servizio, e con il coordinamento
iniziale di Nico Pitrelli del Laboratorio Interdisciplinare della S.I.S.S.A.
Un primo passaggio necessario è stata l’esplicitazione della nostra idea
di narrazione, molto diversa tanto da quella del “terapeuta” [1]
quanto da quella dei “comunicatori” con i quali molti pazienti psichiatrici
erano già venuti in contatto (a Trieste ad esempio sono numerose le trasmissioni
Radio dedicate alla salute mentale, maggiormente votate all’advocacy,
a sostanziare il “diritto alla relazione” con il mondo esterno, denunciare
i così detti stereotipi sulla malattia mentale ecc.). La proposta delle
illness narratives propria della ricerca sociale è evidentemente diversa:
narrare in assenza dello psichiatra per spiegare a se stessi e agli altri
- parlando con il “ricercatore”, figura nuova per i nostri interlocutori
- il senso di quanto si è vissuto, per formulare e raccogliere immagini
su quale sia il “perduto benessere”, perché sia andato perduto, come sia
il “malessere”, come e perché agisca la “cura” ecc., agli occhi di chi
con continuità è stato immerso nell’ordine simbolico della ‘cura psichiatrica’,
nelle definizioni di malattia e di cura che i servizi danno loro, ecc.
Abbiamo presentato quindi la narrative illness ai nostri interlocutori
come sguardo sulla malattia dal suo interno (come forma di expertise ad
altri impossibile, se così possiamo dire), ma contemporaneamente anche
come sguardo sul mondo dei sani dal suo interno, come pensiero “laterale”
sull’ordine quotidiano che la condizione - potremmo quasi dire lo status
- del “malato” permette di elaborare, e in tal senso come pensiero fondamentale
per interpretare le dinamiche relazionali quotidiane che mantengono e
costituiscono inconsapevolmente l’ordine sociale.
In questi primi confronti, apparivano i timori dei nostri interlocutori
(chi è il ricercatore? chi c’è dietro di lui? chi altro ascolterà le parole
registrate? perché proprio noi come testimoni? cosa ci “guadagniamo” noi?)
per nulla scontati, che molto attengono a quelle che Fabietti [2]
ha chiamato “politiche dell’identità” nella ricerca sociale, vale a dire
strategie e forme della presentazione reciproca iscritte in un quadro
di rischi e investimenti individuali, disparità di potere e di informazioni,
timori presenti in ogni indagine sociale ma che qui premevano per trovare
più ampia legittimazione - anche per la normale inclinazione di queste
persone e di chi se ne prende cura a “difendersi dalle energie negative”
- e che infine hanno portato a quello che diverse volte abbiamo poi chiamato
un “patto narrativo” più esplicito. Non solo un discorso più esplicito
con i testimoni sulla narrazione come strumento di ricerca sociale perché
essa sia distinguibile da altre forme della narrazione, che pure essi
conoscono e agiscono quotidianamente sulla scena di cura, ma anche una
maggiore negoziazione sull’utilizzo futuro delle loro parole e sulla loro
comunicazione utile a fugare resistenze e preoccupazioni che agivano con
forza.
In questo contesto, ho pensato che tali “patti” (chiarimenti sulla ‘funzione
narrativa’ dei protagonisti, potremmo dire) divengono elementi centrali
della metodologia laddove i\le testimoni hanno già una vasta esperienza
in termini di narrazioni ‘prodotte’ ma diversamente concepite e finalizzate
(penso non solo a tutti coloro che seguono una psicoterapia, come in questo
caso, ma anche a tutti coloro che sono seguiti dai servizi socio-sanitari:
pensiamo alle indagini sui migranti o sui richiedenti asilo ad esempio,
tenuti a narrare continuamente quanto gli è accaduto a diversi tipi di
operatori sociali), o laddove l’indagine si produce in un contesto di
grande disparità percepita (ovvero dove chi intervista appare “biograficamente”
distante a chi narra), dove il rischio di manipolazione e di danno percepiti
sono elevati (a chi parlerai di queste mie cose? appunto).
Dopo questi passaggi negoziali, l’adesione alla nostra proposta è stata
buona; tra le persone disponibili, ne sono state selezionate 22, in base
alla “diagnosi severa” (persistenza del problema nel tempo, esperienze
anche transitorie di tipo allucinatorio-dissociativo ecc.), ed alla frequentazione
dei servizi psichiatrici almeno decennale (potremmo definire in questo
modo il nostro “campionamento ragionato” , “corretto” poi anche in base
a genere, titolo di studio, l’età [3]).
Vorrei aggiungere rapidamente qualcosa sulla “diagnosi psichiatrica”.
Nel riesaminare il materiale raccolto con le prime interviste - al fine
di strutturare le “ipotesi guida” circa le tipologie concettuali e le
argomentazioni ricorrenti utili ad orientare le interviste successive
[4] - ci siamo accorti di una dinamica
alla quale non avevamo pensato. Da una prima e rudimentale analisi delle
conversazioni (osservando cioè quali erano i nostri dispositivi “discorsivi”,
gli interventi, i momenti di incoraggiamento o di arresto utilizzati durante
l’intervistare al fine di facilitare il racconto), ci siamo resi conto
che nel caso di diagnosi riconducibili alla “schizofrenia” vi erano più
sovente atteggiamenti di resistenza ad “uscire” da un tema già impostato
(probabilmente per paura di una frammentazione eccessiva della narrazione),
mentre nel caso delle diagnosi riconducibili alla “depressione” ve ne
erano altri (un modo potremmo dire più paternalistico di alleviare, di
ridurre il silenzio e la sosta nei momenti del dolore ad esempio).
Gli intervistatori sono sempre parte del “con-testo”, come sempre cioè
essi contribuiscono all’andamento della narrazione, come sanno bene coloro
che conducono personalmente le interviste [5],
che esse siano “strutturate” o relativamente “destrutturate”. Ciò avviene
non soltanto in modo consapevole, attraverso il richiamo esplicito ai
nodi tematici o le domande, ma anche in maniera inconsapevole, seguendo
uno stile personale di incoraggiamento alla narrazione, di uscita dalle
empasse ecc. [6]. In questo caso, in
particolare, gli intervistatori apparivano “impressionati” dalla “schizofrenia”,
parola potente che anima il nostro immaginario e orienta le conversazioni.
Per questo, abbiamo deciso infine di non conoscere la diagnosi e di adottare
come categoria di analisi la “diagnosi narrata”, quella che sempre appariva
nei racconti e che al di là di specifiche ulteriori sarà qui ricondotta
a due vaste tipologie riferite principalmente alla “dissociazione” (circa
2\3) e alla “depressione grave” (circa 1\3, come vedremo in seguito).
b) Queste storie di malattia possono essere intese come attività di
ricucitura di “periodi frammentati” del vissuto in una unica “sequenzialità
biografica”.
I nostri testimoni erano in cura nei servizi psichiatrici da almeno 10
anni (e mediamente da 16 anni). Per loro la malattia non solo è stata
un “punto di rottura” o di “svolta” che dire si voglia [7],
ma è stata sopratutto la lunghissima esposizione ad esperienze differenziate
di malessere, a idee instabili circa il possibile-poi impossibile-poi
possibile ritorno al “oggetto di valore perduto”, mutuando una espressione
famosa [8], vale a dire alla condizione
psichica precedente la crisi, ad una condizione mentale più largamente
impensata o sulla quale non si condivideva esplicitamente il discorso
con gli altri, ecc. Si tratta dunque di racconti su una malattia prolungata
e da tanto esposta ad “altri che curano”, anche se in questo caso è improprio
chiamarla “malattia cronica” proprio perché i suoi esiti futuri hanno
confini sfumati, anche “scientificamente” più indefiniti (la psichiatria
si riferisce in maniera particolare alla predizione, e questa è un’altra
differenza ontologica rispetto ad altri contesti medici), insomma di illness
narratives in prima persona centrate su un’esperienza di malessere-benessere
oscillatorie nel tempo.
E’ questa una condizione particolare di sofferenza, oggi definita nei
termini di malattia e quindi collocata nel contesto della cura medica
e del “diritto” alla cura, che interroga in modo particolare la categoria
esistenziale della “restituzione” alla normalità - per tornare a Frank
(op. cit.) che parla appunto di “restitution narratives” - e che sfida
la cura medica come “via della guarigione”, o la guarigione come rientro
nel mondo quotidiano (fattivamente inteso come contesto della socialità
produttiva ecc.) [9]. Rispetto alla
gran parte delle altre malattie, quindi, non solo il paziente psichiatrico
con diagnosi severa oscilla tra diverse idee di uscita dal male e rientro
nel mondo dei sani che si hanno nelle diverse fasi di malattia e di cura
psichiatrica, ma anche la società oscilla, non sa come e dove collocare
univocamente oggi la “condizione” che un tempo fu quella del “matto” rispetto
all’idea di restituzione. Non solo quindi la malattia mentale ci pone
davanti a costrutti di desease e illness specifici, ma anche ad una sickness
specificamente oscillatoria, potremmo dire rifacendoci ad ormai famosi
schemi [10].
A partire da queste considerazioni, scopo dell’indagine è stato lavorare
insieme ai testimoni sull’idea di “sequenza biografica” rispetto alle
polarità immaginarie di benessere-malessere psichico, identificando “periodi”
o fasi di “passaggio” [11], momenti
biografici identificati come “discontinuità” rispetto alla condizione
di salute, salti - ora più vicino, ora più lontano - dalla meta di un
“valore perduto” (definito in molti modi, nei termini di concordia con
il mondo esterno o di equilibrio interiore, come vedremo). Certo, i punti
di svolta sono momenti biografici che appaiono al presente (al momento
della narrazione), in tal senso momento di “ricucitura”, esercizio concreto
di “consequenzialità” [12], di costruzione
di costruzione di senso da attribuire alla sequenza biografica.
Ovviamente, nel particolare ambito delle mental illness [13]
queste ricuciture biografiche, questi ri-posizionamenti narrativi del
soggetto rispetto alle fasi del “benessere perduto” e riperduto, avvengono
sopratutto in relazione a diversi luoghi della cura psichiatrica attraversati,
che tra loro appaiono ai nostri testimoni come differenti tra loro, discontinui
più di quanto probabilmente accada in altri contesti della medicina: “ho
visto tutte le diverse facce dell’uomo nelle diverse facce degli psichiatri”
dice efficacemente uno dei nostri testimoni.
Questo rende particolarmente interessanti le ricuciture biografiche delle
svolte vissute da queste persone, particolarmente legate non solo all’idea
di malattia ma anche appunto all’idea di cura, che si modifica nel tempo
e che non è univocamente intesa neanche dalla stessa medicina.
Più tecnicamente, le interviste pilota sono state inizialmente poco strutturate,
“aperte” come si dice ma al tempo stesso “centrate” sulla esperienza di
malattia e di cura a partire da un antefatto (l’incontro si apriva testando
la capacità di stabilire l’esistenza di una condizione perduta in nome
della quale si lavora insieme ai curatori), e si sono concluse nel momento
in cui il\la intervistatore ha identificato in maniera soddisfacente (stabile)
la sequenza tra le fasi, operando l’identificazione delle svolte significative
e la loro messa in ordine temporale ed effettuando un passaggio sull’idea
del “finale” (di possibile esito del proprio percorso) [14].
Se le persone con cui è stata ricostruita la storia sono state 22, le
storie che hanno pienamente soddisfatto questo iter narrativo e che sono
inserite in questa analisi sono 15.
Le “sequenze biografiche” sono state poi analizzate utilizzando categorie
già assunte nelle indagini precedenti, effettivamente performative anche
per catalogare i nostri testi. Ho in buona parte mutuato le categorie
di analisi di Cardano (Gergen modificato) [15],
provando a coglierne elementi specifici in questo contesto di indagine.
Vi è un “antefatto” appunto, la narrazione di una condizione precedente,
che deve esserci per consentire l’idea stessa di “perdita” e l’idea di
“malessere”, con tutto il suo apparato ideologico sulle cause scatenanti;
poi vi è la “crisi” (la prima crisi come esperienza di “soglia” e le altre
crisi); poi il “contratto di cura” per un ritorno o un nuovo approdo al
benessere, ecc.
Più precisamente, ricomponendo i nodi della struttura narrativa ricomposta
per ciascuno:
- Antefatto: la collocazione narrativa di un “prima”, di ciò che si
ricorda come “l’altra” condizione mentale (un “oggetto di valore” perduto);
- Soglia: l’esperienza di come si entra dentro al male-essere (di come
lo si identifica e definisce da un lato, di come ne si ricorda la prima
esperienza corporea e psichica dall’altro lato);
- Andirivieni: come si opera un su e giù tra meglio e peggio, tra gradualità
del bene (essere) e del male (essere) che quindi vengono ad essere sempre
più definiti (quali sono i periodi di passaggio, quali le svolta verso
l’alto o il basso, ecc.);
- Finale: come andrà a finire (per me e per tutti gli altri);
- Infine, ricomposizione di una direzione assunta dalla sequenza (pro/re-gressione):
è la ricomposizione narrativa delle oscillazioni e delle svolte che nel
complesso dà una direzione al proprio cammino, collocandolo rispetto alla
meta.
c) Cogliere la variabilità interna alle narrazioni è possibile “triangolando”
diversi tipi di analisi.
L’analisi dei testi ottenuti dagli incontri (integralmente sbobinati)
ha proceduto per steps. In primo luogo abbiamo ricostruito l’intero percorso
dei singoli, ricomponendo i frammenti narrativi che si riferivano ad un
medesimo periodo e collocando le svolte rispetto alla sequenza. L’analisi
del contenuto di tipo qualitativo ha poi permesso di identificare le argomentazioni
ricorrenti circa i “passaggi” nella malattia, circa l’antefatto, la soglia,
le crisi, i diversi “malesseri” attraversati (ora legati all’idea di “malattia”,
ora di “sofferenza”, ora di “disagio”), alle “cause” (legate ora all’idea
di “meccanismi biologici” ora all’idea di “colpe” ora all’idea di “trauma”)
e alle “cure” (legate ora all’idea di “parola-terapia” ora all’idea di
“farmaco-terapia”). Per motivi di spazio, non mi soffermerò particolarmente
sulla descrizione di tali categorie argomentative, che ritroveremo nell’analisi
multivariata lessicale presentata in seguito. Nella fase dell’analisi
qualitativa del testo, sono state inoltre ricercate e catalogate alcune
metafore ricorrenti nei racconti, dispositivi utilizzati in particolare
per spiegare l’esperienza concreta, psico-fisica, delle crisi depressive
e\o dissociative (“ti senti come …”; “è come se…”), sulle quali per motivi
di spazio non mi soffermerò [16].
Infine una analisi lessicale di graduale complessità - effettuata tramite
il software TLAB (prima la associazione tra lemmi, poi l’analisi delle
Componenti Multiple, poi l’analisi dei Clusters) - ci ha permesso di verificare
come le diverse forme argomentative individuate precedentemente (e identificate
in alcune lemmi e insiemi di lemmi) trovino una diversa distribuzione
nelle narrazioni: su questo passaggio ho maggiormente focalizzato il presente
saggio.
d) Trieste non è un posto come gli altri, forse.
Mi pare utile compiere un breve richiamo al luogo in cui si è svolta l’indagine,
la città di Trieste.
Le ricerche centrate sulle mental illness narratives sono relativamente
numerose, non solo all’estero ma anche in Italia. Uno degli interessi
è quello di verificare se e come Trieste rappresenti un contesto particolare
nello scenario nazionale della cura e della socializzazione della sofferenza
mentale. È importante ricordare infatti che non solo è stata una delle
sedi operative di Basaglia, negli anni Sessanta, Settanta e Ottanta indicata
come luogo di sperimentazione avanzata della riforma (della democratizzazione
interna dei luoghi psichiatrici, della socializzazione, eccetera), ma
che anche nell’era post-basagliana tale attenzione è parsa mantenersi
(“Impazzire si può” è un festival che testimonia di quante iniziative
siano fatte in questo senso, ad esempio). Insomma, vi sono indizi di una
particolare e prolungata attenzione alla dimensione sociale della sofferenza
mentale e numerosi lavori indicano qui un passaggio più convinto da servizi
accentrati (strutture come ospedali, manicomi, Diagnosi e Cura) a forme
più comunitarie di cura rispetto a quanto avviene in altre aree del paese.
Una delle domande particolari della ricerca era quindi relativa alla connotazione
dei nostri risultati rispetto a quelli ottenuti in altri ambiti: qui si
coglie un livello di comunicazione differente con gli psichiatri? apertura
e socializzazione maggiore? speranza maggiore in termini di cronicità
reversibile?
Infine, il desiderio era anche quello di esplorare le narrazioni per compararle
a quelle raccolte in altri contesti.
2. La “sequenzialità”: l’andamento della sofferenza e il presunto
finale
Come abbiamo già detto, la narrazione di un’esperienza di malattia il
cui incipit si colloca lontano nel tempo conduce necessariamente all’idea
di “evoluzione” della malattia o meglio ad una collocazione ripetuta del
sé narrativo rispetto ad eventi di “questo” o di “quel” periodo. Dalla
presentazione degli antefatti così come definiti, delle crisi e della
prima esperienza diretta (corporea e psichica) dei momenti di sofferenza
acuta e poi dei momenti di sollievo, si arriva infine ai passaggi narrativi
nei quali i testimoni forniscono valutazioni complessive circa le oscillazioni
di cui si parla.
La direzione ricavata dalla traiettoria (complessivamente rivolta verso
l’altro o verso il basso, verso il ‘meglio-essere’ o il ‘peggio-essere’),
dipende certo da ciò a cui si aspira e quindi ancora una volta dal punto
di vista del “presente narrativo”: ad esempio, se si vuole tenacemente
una vita come quella degli altri (la restituzione, come si diceva), allora
anche un’aumentata capacità di gestione della sofferenza risulta poco
efficace per giudicare in termini positivi l’andamento della malattia.
Viceversa, se l’oggetto di desiderio perduto è una presentazione efficace
ed eroica del sé, la capacità di ‘soffrire meglio’ diviene un traguardo,
ecc. Il dominio materiale (l’eliminazione dei sintomi ad esempio) e il
dominio simbolico (la comprensione dei sintomi, o più in generale una
narrazione ricca di senso su quanto ci accade) si presentano nel nostro
insieme di interviste come due diversi “oggetti andati perduti” con la
malattia psichica (e quindi due diverse modalità di definire il bene perduto).
Come vedremo, a seconda della loro prevalenza e della loro composizione
avremo diverse valutazioni “interne” delle traiettorie.
«La fase più delicata è quando si comincia a guarire perché poi la
ricaduta è tragica, fa male quasi come la prima volta e direi che tanto
dici di star bene, tanto più ricadi e stai male. E questa è una cosa che
logora sia la persona che vive la sofferenza, sia l’ambiente familiare,
perché la famiglia spera con te, ti vede rifiorire, rinascere e poi improvvisamente
“patapuf”, di nuovo nella tragedia e supplichi, piangi, cammini per casa
come un fantasma, ti nascondi, ti chiudi, non ti vuoi far vedere per non
far soffrire gli altri, specialmente i genitori che fino a ieri erano
felici, tornano magari da una passeggiata tutti felici che finalmente
hanno fatto una passeggiata e ritornano a vederti proprio nel buio, in
bagno, chiusa lì, persa di nuovo. Ma la ricaduta è una fase, è un cammino
che fa parte del percorso verso una guarigione, è come il gambero, fai
cinque passi avanti e magari sei indietro però quei cinque passi comunque
ti sono serviti a vedere che puoi procedere e forse a sapere che indietreggi.
All’inizio è dura ammettere che può servire, ma è molto importante. I
dottori dicono sempre: “Guarda che riavrai i momenti negativi e guai se
ti fai trovare impreparata, perché è lì che puoi decidere per sfinimento
di farti fuori”» (Margherita).
«Anche se in un primo momento mi sembrava di aver fatto dei passi indietro
come i gamberi ho capito che dei passi indietro rispetto all’evoluzione
della propria personalità, davanti alle proprie debolezze e manchevolezze,
sono ammessi anche e proprio se poi il percorso è indirizzato, secondo
me, verso il raggiungimento di qualcosa di buono» (Maria).
«Purtroppo la mia famiglia non capisce il mio percorso verso la guarigione,
a loro devo nascondere tutto. Loro sono arrabbiati con i servizi, li volevano
denunciare, mi dicevano: “Ti rovinano, ti drogano, non sei più tu”. Ma
lo scopo è stare meglio e non è essere sempre io» (Sara).
«Ancora oggi non so valutare effettivamente se ci possa essere la guarigione
da questo tipo di malattie o se invece probabilmente si tratterà più di
adattamento che fa stare bene» (Lara).
Per inquadrare sinteticamente queste traiettorie, ho adottato le tipologie
di racconto della malattia mentale utilizzate da Cardano (2007) che riprendono
e modificano i modelli di Gergen (si vedano note precedenti).
Da un lato vi sono le modalità di composizione biografica detta “tragica”
(nel nostro caso 5), che esprimono l’idea di una stabilizzazione dello
stato di sofferenza a un livello di minor ben-essere (di minor dominio
sia materiale che simbolico della propria esistenza) rispetto all’antefatto,
vale a dire all’incipit (alla speranza e al progetto di vita) narrato
come esperienza fatta precedentemente all’attraversamento della “soglia”.
Una variante è la ricomposizione biografica che potemmo chiamare “satirica”
(così si caratterizzano 3 storie) dove prevale la narrazione di uno stato
di impossibile ritorno all’oggetto desiderato ma in cui è più centrale
la descrizione di ripetuti e diversi tipi di accanimento della sorte,
una sorta di “presa in giro” del destino (così è percepita) rispetto alla
quale non ci si può opporre.
Vi è poi un modello “cavalleresco”, nel nostro insieme quasi assente (1
caso): sono le narrazioni di un miglioramento graduale, di una lenta ascesa
verso il benessere, di approdo al meglio, perdurante e stabile, che non
induce al perpetuo su e giù. Questo modello, probabilmente si avvicina
di più alle restitution di Frank già citate e si compie come adesione
piena del narratore al sick role set (ad un insieme di ruoli attribuiti
al malato) con una forte motivazione alla cura e allo stile di vita “sano”,
a prendere come vita di riferimento quella dei “non malati”, gruppo al
quale si aspira ritornare, anche se in tutti i casi di several mental
illnessin realtà ci si assesta in una condizione percepita come maggiormente
“compatibile”.
Un altro modello narrativo è invece quello della “saga eroica” (6 casi),
con l’esplicita narrazione di oscillazioni ripetute, di crisi considerate
come “ricadute” (materialmente o potremmo direi “corporalmente”) ma anche
come “sfide” (simbolicamente), dell’alternanza tra bene e male nel proprio
iter personale, come appunto in quelle storie in cui all’eroe è richiesta
non tanto la capacità di portare a termine un compito in maniera conforme
all’obiettivo (la conquista dell’oggetto di valore) quanto la capacità
di resistere, di restare in se stesso, nella sfida di essere esposto alla
mancanza perpetua del proprio oggetto di valore. La resistenza e la tensione
al miglior sé nella sciagura divengono, in questo caso, il “nuovo” oggetto
di valore al di là del raggiungimento dell’obiettivo iniziale o del contratto
iniziale (in questo caso la stabilità psichica).
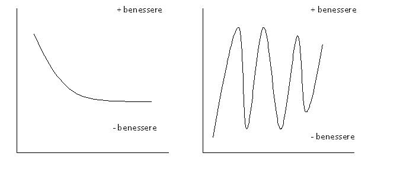 Fig.
1 Andamento dell’esperienza biografica nel modello Narrazione Tragica
e Saga Eroica
Fig.
1 Andamento dell’esperienza biografica nel modello Narrazione Tragica
e Saga Eroica
Come evidenzia lo schema qui sotto inserito, indicativamente possiamo
dire che nella nostra indagine vi è una polarizzazione tra modalità tragiche
e modalità eroiche, con particolare diffusione di un modello di narrazione
centrato sull’andirivieni tra bene e male e sull’esperienza delle ricadute,
mentre sono relativamente assenti le narrazioni su una evoluzione graduale
e nel complesso monodirezionale. Come si può osservare dallo schema sottostante
(e come vedremo nell’analisi multivariata), la distribuzione pare differire
sopratutto tra testimoni aventi titolo di studio alto e titolo medio-basso:
1. Fabio, scuole medie (sogg.01), percorso tragico-satirico (o eroico
discendente); esperienze di dissociazione; primo accesso giovanile ai
servizi psichiatrici.
2. Giovanna, scuola superiore (sogg.02), percorso tragico-satirico (o
eroico discendente); esperienze di dissociazione; primo accesso giovanile
ai servizi.
3. Roberto, scuole medie (sogg.03), percorso tragico; esperienze di dissociazione;
primo accesso giovanile ai servizi.
4. Margherita, scuola superiore (sogg.04), percorso eroico ascendente;
esperienze di dissociazione; primo accesso adulto ai servizi.
5. Caterina, scuole medie (sogg.05), percorso tragico; esperienze di depressione;
primo accesso giovanile ai servizi.
6. Davide, scuola superiore (sogg.06), percorso eroico; esperienze di
depressione; primo accesso giovanile ai servizi.
7. Eleonora, scuole medie (sogg.07), percorso tragico; esperienza di depressione;
primo accesso adulto ai servizi.
8. Sara, scuole medie (sogg.08), percorso tragico; esperienze di dissociazione;
primo accesso giovanile ai servizi.
9. Carlo, scuole medie-superiori (sogg.09), percorso cavalleresco; esperienze
di dissociazione; primo accesso giovanile.
10. Luca, università (sogg.10), eroico ascendente, esperienze di dissociazione;
primo accesso giovanile.
11. Elisabetta, scuole medie (sogg.11), tragico; esperienze di depressione;
primo accesso giovanile.
12. Maia, università (sogg.12), eroico; esperienze di depressione; primo
accesso adulto.
13. Lara, scuola medie-superiori (sogg.13), tragico-satirico; esperienze
di dissociazione; primo accesso giovanile.
14. Alberto, università (sogg.14), eroico ascendente; esperienze di dissociazione;
primo accesso adulto.
15. Maria, università (sogg.15), eroico ascendente; esperienze di depressione;
primo accesso adulto.
«Accettare la malattia può portare a cambiare il proprio modo di essere,
al desiderio di conoscere altra gente, si diventa un’altra cosa, un’altra
persona. Non è detto affatto che quella che diventiamo non sia proprio
quella che da piccoli speravamo di essere» (Margherita).
«Comincio invece a pensare che sulla faccia della terra esistono uomini
che si troverebbero bene con me, ma poi penso che sono vecchia ed è troppo
tardi per sperimentare, eppure quando sono più allegra mi viene da pensare
che in realtà questi poveretti non sanno cosa si perdono perché sono diventata
capace, intelligente di testa anche se fuori di testa e adesso si sarei
anche di buona compagnia» (Maia).
Nel nostro insieme di testimonianze troviamo una buona presenza del tipo
di narrazione che potremmo chiamare “saga eroica ad incremento o “progressiva”.
In questo caso, vi è una produzione considerevole di considerazioni su
come «crisi dopo crisi si impara che passano», su come «il tunnel poi
si faccia meno nero quando poi prevedi la luce, e non è lo stesso buio
di quando non immagini la luce», sul fatto cioè che “prevederne” la fine
significa andare oltre ai propri stati psichici più dolorosi. La sofferenza
psichica viene intesa come palestra dell’immaginario, che sviluppa capacità
intellettive nuove. Riuscire a dare un significato alle crisi più nere
significa espressamente non ritrovarsi più nelle stesse “nere condizioni”;
immaginare di essere migliorati (di aver incrementato le proprie capacità)
anche in presenza di malattia produce di per se stesso salute. O meglio,
i\le testimoni sottolineano come il dominio simbolico della ricaduta pone
in una nuova condizione rispetto ad essa, più positiva rispetto agli inizi,
sebbene in presenza degli stessi gravi sintomi, di nuovi tentativi di
autolesionismo ad esempio, e anche laddove la malattia resta concepita
come cronica. È quindi una tipologia narrativa sul “dimorare nella malattia”
(la cronicità appunto) che già abbiamo incontrato in altre ricerche: penso,
ad esempio, alla categoria RP3 di Cardano (2007), alla traiettorie progressive
di cui lui parla, penso a Cesare e Noemi, che pure tuttavia mi sembrano
casi leggermente diversi dai miei poiché erano persone che si sentono
in via di guarigione o comunque meno esposte alla forza delle regressioni,
al pericolo di angosce che tornano nelle forme più crude ad esempio.
Ciò che qui pare più evidente invece è forse la relativa numerosità di
questo tipo di storie rispetto a quelle cavalleresche o inclini alla modalità
della restituzione: in queste testimonianze, il concetto di “guarigione”
assume uno spazio più esiguo (e come vedremo la parola stessa è pressoché
assente).
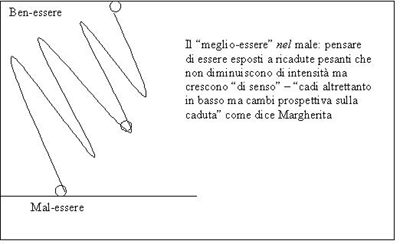 Fig.
2 Modello narrativo della Saga Eroico-progressiva
Fig.
2 Modello narrativo della Saga Eroico-progressiva
Ho trovato particolarmente stimolante questa visione eroica circa la malattia
cronica poiché essa re-interroga dall’interno il concetto di salute, andando
direttamente alla sua fondazione epistemologica: la salute come incremento
delle esperienze di “dominio” innanzi tutto simbolico della propria vita,
come incremento di un potenziale personale di rielaborazione a partire
da una condizione incarnata, concretamente umana e particolare. Al di
là delle definizioni altisonanti dell’OMS, è difficile solitamente definire
un incremento di salute nel persistere di uno stesso livello di disfunzione.
Al contrario, come dice Margherita, «adesso ho sempre quella stessa malattia,
mi dicono, ma io so che quando entro nel tunnel poi ci esco ed è per questo
che non mi suicido»: sviluppare capacità di vedere nel buio (per restare
in metafora) significa produrre luce.
La differenza tra esperienza tragica ed esperienza eroica infatti appare
sostanzialmente nel modo di pensare alla crisi successiva come tradimento
o fallimento del contratto di cura (nel primo caso) o piuttosto che come
sfida al migliore dominio di sé (nel secondo caso). Da un lato, «L’ultima
volta sono andata avanti due mesi, sono dimagrita, non dormivo, non mangiavo:
l’ultima crisi è stata proprio brutta, orribile, terribile, perché ogni
volta è sempre peggio perché è ancora e ancora e capisci che non è mai
finita» (Elisabetta). Dall’altro lato, al contrario, la ricaduta
è vista come graduale conquista della verità su di sé, che è poi diviene
lo scopo, il valore perduto su cui si spostano queste narrative: «Ciò
che desidero è capire torti e ragioni, comprendere la natura delle persone
anche se comprendere avviene proprio a forza di traumi. La mia vita va
verso il realismo a forza di traumi. A un certo punto, in qualche maniera,
sono andata fuori della realtà, ho idealizzato tutto troppo ed è per questo
che bisogna cercare di prevenire la depressione. Ma poi è comunque qualcosa
che ti porta alla crescita se affrontata con le persone giuste, nel modo
giusto, ti porta a una conquista di te stessa e a una maggior consapevolezza.
Perché la depressione è soprattutto una lacuna di appartenenza, di appartenersi,
di aver capito le qualità buone. Perché è evidente che i depressi vedono
solo i difetti di se stessi. La mia malattia sottolinea il fatto che,
secondo me, non ho saputo vedere le qualità buone su cui appoggiarmi nei
momenti di difficoltà. Ma a forza di traumi mi sono avvicinata alla vita
realistica. E se mio marito mi avesse dato un po’ di più tempo... E invece
lui, sportivo, forte, campione militare mondiale di pallanuoto, doveva
avere tutto. Tutto, tranne sapere però chi sono io e chi è lui» (Margherita).
3. Verso la definizione di alcuni “profili narrativi”: sublimarsi,
restituirsi, stigmatizzarsi
Vorrei ora tentare un’interpretazione più complessiva della variabilità
contenuta nelle narrazioni raccolte, cercando di stabilire in che modo
i diversi temi affrontati (sistemi di spiegazione circa le cause della
sofferenza, l’idea di cura e di terapia) si associano tra loro, e in che
modo essi possono costituire diversi “profili narrativi”, diverse ricostruzioni
complessive della propria esperienza di several mental illness.
Anche alla luce delle analisi precedentemente compiute interpretiamo i
risultati conseguenti alla Analisi delle Corrispondenze Multiple (ACM)
effettuata sempre grazie al supporto TLAB [17].
Complessivamente, l’analisi ha permesso di identificare tre fattori, potremmo
dire tre dimensioni alle quali legare la variabilità contenuta nelle narrazioni,
fattori cui si associano le diverse caratteristiche individuali. Come
mostra lo schema sottostante, considerando l’associazione LEMMI x VARIABILI
(l’output numerico e grafico di TLAB sono qui semplificati per motivi
di leggibilità), emerge l’associazione significativa di alcune parole
al primo fattore, che spiega il 41% della variabilità, a sua volta relato
significativamente alla variabile di genere (uomini e donne); il secondo
fattore è invece associato al titolo di studio (30% variabilità), mentre
il terzo fattore alle modalità di entrata nel servizio psichiatrico (e
in maniera inferiore al tipo di crisi descritte, dissociative o depressive).
Guardando tabelle e grafici, possiamo dire che vi è l’incidenza significativa
di alcune caratteristiche rispetto all’utilizzo delle parole e alla loro
associazione in concetti (in diverse forme di concettualizzazione narrativa
della sofferenza):
- il genere pare influire più chiaramente rispetto alla definizione
del male e alla definizione dell’oggetto di valore perduto con la malattia
(ciò di cui si va alla ricerca attraverso la cura);
- il percorso psichiatrico (momento dell’entrata in cura, tipo di auto-diagnosi
più propriamente dissociativa o depressiva del male) pare incidere sull’idea
stessa di cura e di psichiatria (la parola-terapeutica o piuttosto il
farmaco-terapeutico);
- il titolo di studio pare incidere maggiormente sui concetti legati alle
cause (processi di maturazione della malattia legati all’individuo o piuttosto
alla sua interazione con l’esterno, di natura organica o piuttosto relazionale)
e all’evoluzione del malessere.
Il genere
In senso più generale, possiamo dire che il genere appare un elemento
ordinatore rispetto alla rielaborazione della sofferenza psichica. Ciò
non stupisce affatto, poiché il genere (parola che fa riferimento più
esplicito alla costruzione sociale della differenza sessuale) è, come
si sa, uno degli elementi biografici maggiormente strutturanti l’esistenza.
In questo caso, vi è una maggiore ridondanza di osservazioni e di sfumature
circa le relazioni vissute nel tempo lontano e la loro ricaduta su di
sé. Nei racconti femminili vi è una maggiore attenzione alle percezioni
corporee e potremmo dire alla storia del proprio corpo, memoria forte
delle sensazioni infantili e nostalgia forte. Inoltre, lo spazio femminile
della narrazione è più facilmente vasto, uno spazio che tende a occupare
per ciascun aspetto (le cause, l’andamento della malattia, la cura) le
considerazioni sulla “vita intera” (diffuse le espressioni sul “prima”,
“in rapporto a” ecc.), rispetto alla centralità assunta dall’adesso e
dalle sue connotazioni (o meglio la separazione narrativa tra “periodi”)
nella narrazione maschile.
Una grande distanza tra i due universi narrativi di genere nelle nostre
testimonianze è rispetto all’oggetto di valore perduto e a come sia andato
perduto. Il discorso femminile è maggiormente centrato sulle “relazioni”
come luogo ambiguo per eccellenza, di salvezza e di malattia, sulla “casa”
come luogo del tradimento e dell’accompagnamento, l’aspirazione all’altro
come realizzazione negata. Il discorso maschile è principalmente orientato
sulla “mente”, sul “cervello”, sulla funzione mentale danneggiata, sul
processo in ottica neurologica che si traduce in funzioni negate (la centralità
del “lavoro” nei discorsi maschili è davvero evidente). La sofferenza
ha cicli, spazi, andamenti circolari che impediscono agli uomini le occasioni
giuste, i lavori giusti, le compagne giuste, la realtà giusta che «non
prevede cicli ma solo corse in avanti», come dice un testimone.
In tal senso l’approccio critico nei confronti della società e dei suoi
valori (ad esempio sulla facilità con cui vengono stigmatizzate le persone
sofferenti) trova universale collocazione ma diverse argomentazioni nei
due universi: la lotta tra i sessi, la violenza maschile sulle donne,
i modelli della performance e la menzogna borghese per le donne; la difficoltà
di collocazione nel mondo del sani, la precarietà, l’impossibilità di
fare ciò che si potrebbe fare perché non si è apprezzati per gli uomini.
In generale l’analisi evidenzia un elemento prevedibile, la maggiore aspettativa
degli uomini circa la normalizzazione, la collocazione sociale ad esso
legata, la “restituzione” alle regole del gioco, che pure riguarda anche
le donne ma in maniera differente, meno nei termini di posizione sociale
ottenuta e più nei termini di “buone prestazioni relazionali”.
Il titolo di studio
Anche il titolo di studio pare influire sulla modalità di raccontare la
propria esperienza di malattia, in particolare rispetto alla concettualizzazione
della relazione tra individuo e ambiente circostante nel processo di “ammalamento”,
se così lo possiamo chiamare. Da un lato, vi è l’allocazione esterna dell’incipit
e del processo (quello che abbiamo chiamato “cause esogene”); dall’altro,
una più sfumata incapacità di disgiungere l’esterno dall’interno, un linguaggio
centrato sulle interazioni che porta ad attribuirsi parte della pre-disposizione
e della natura del malessere (“cause endo-esogene”). Questa diversa allocazione
delle responsabilità pare legarsi al modo di proiettare la fine del proprio
viaggio verso l’alto o verso il basso, di vivere appunto la cronicità
(la durata nel tempo delle crisi e le oscillazioni) come una strada che
può condurre in alto (verso l’oggetto di valore smarrito con la sofferenza)
o in basso (più lontano da esso).
Potremmo parlare qui di “individualizzazione” più meno spinta della sofferenza
mentale. Da un lato, vi sono le persone che hanno studiato più a lungo
e che (in generale, tranne un caso) appartengono a famiglie della medio-alta
borghesia friulana (nel nostro caso, il titolo di studio è – come spesso
avviene – una buona proxi del ceto).
Nelle loro narrazioni vi è un forte accento sulla natura circolare dei
processi di sofferenza (individuati come ‘reazioni a reazioni’, tanto
per intenderci, anche quando si tratta di processi che interessano il
livello organico o il proprio cervello). Questo porta alla riflessione
sulla società come realtà ammalante ma anche a una più concreta, sentita
narrazione sulle proprie inclinazioni, debolezze. Una sorta di maggiore
responsabilizzazione, insomma, a tratti colpevolizzante, che tuttavia
pare avere come contraltare un maggiore dominio simbolico della sofferenza,
una visione eroico-progressiva (la conoscenza della propria debolezza
come via di salvezza). In tal senso, l’istituzione medica di stampo moderno
(prevalenza di farmaci e omologazione dei percorsi) è qui osteggiata con
lucidità, ritenuta grossolana nei suoi errori ecc., ma la voce del proprio
psichiatra è invece fortemente interiorizzata (molti i discorsi che tendono
ad attribuirsi un’expertise sia in chiave psico-analitica, più al femminile,
o farmacologica, più al maschile). Che sia in chiave psico-relazionale,
mistico-spirituale, bio-medica, la tensione alla “maturazione della verità”
rende queste narrazioni molto auto-centrate: l’individuo è al centro,
ha contribuito con le sue reazioni alle reazioni altrui, e oggi cerca
sollievo alla sofferenza nella sua capacità di svelare questo ordine simbolico
e relazionale, prima incassato inconsapevolmente. Più sfumata invece è
la narrazione della propria collocazione ‘funzionale’ nel mondo, delle
esperienze reali di contrapposizione, delle dinamiche di potere visibili,
se così si può dire.
Per quanto riguarda, invece, coloro che hanno un titolo di studio più
basso, vi è una maggiore ricorrenza all’allocazione esterna delle responsabilità
(le “eso-cause” sia in chiave organica che relazionale). Molto più diffusa
è la lettura in chiave bio-medica, con la nozione stessa di “cervello”,
di “dis-funzione”, di “trauma cranico”, eccetera. Queste storie sono più
fortemente caratterizzate dalla “violenza”, “morte”, sciagure familiari
indicate come incipit del male che sovrasta il singolo, con una idea forte
di dipendenza del singolo dall’esterno (al destino prima, alla medicina
poi). È più presente qui l’idea di restituzione, di ambìto ritorno al
mondo dei normo-funzionali. Sono le narrazioni in cui l’oscillazione legata
alle crisi è percepita come “fallimento” della cura (altra parola diffusa),
come esclusione dalla promessa di normalità.
L’iter psichiatrico e l’esposizione alla medicina
Un altro elemento che pare incidere sulla narrazione della propria esperienza
è il tipo di iter psichiatrico seguito: ricovero più o meno precoce nelle
strutture psichiatriche, numero di cambi rispetto alla struttura (pochi
o molti), la diagnosi (così come riferita ed auto-attribuita rispetto
alla natura delle crisi). A questi aspetti (variabili) pare legato il
modo di narrare la cura. Da un lato, tra coloro che sono giunti più maturi
all’incontro con i servizi psichiatrici, appare una maggiore propensione
ai racconti circa il proprio “dottore”, lo psichiatra inteso come “psico-analista”,
in una relazione personalizzata che per quanto conflittuale è percepita
come “scelta” (tutte parole più presenti) e sostenuta nel tempo. Queste
narrazioni sono quelle in cui emerge più esplicitamente l’idea di una
doppia psichiatria o meglio le narrazioni sul contrapporsi di diverse
proposte psichiatriche percepite (almeno in parte) come contraddittorie
nel tempo, giudicate secondo i propri valori (con riferimento all’ “umanità”
dello psichiatra, al “rispetto” ecc.) prima che in termini di efficacia.
L’età più avanzata al primo ricovero potrebbe corrispondere alla maggiore
maturità o, se vogliamo, in qualche modo ad un’autorevolezza del soggetto
(viene citata in modo minore l’interposizione dei parenti, ad esempio).
Dall’altro lato, è maggiore il riferimento invece ai “centri_di_igiene”,
all’istituzione di cura intesa come “mura” e come spazi fisici, con una
maggiore centralità dei “farmaci”, cuore del discorso sulla cura.
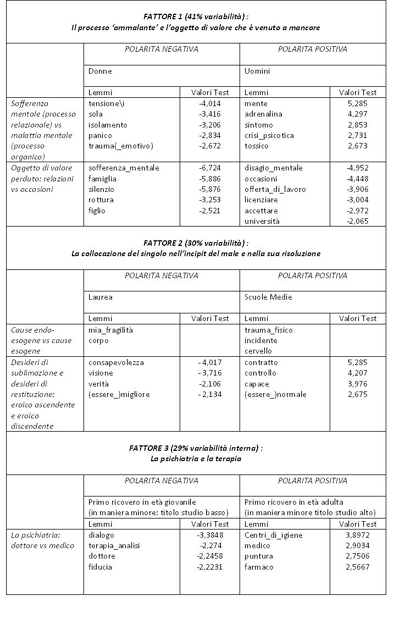 Tabella
1 Analisi delle Corrispondenze Multiple, associazione lemmi x variabili
Tabella
1 Analisi delle Corrispondenze Multiple, associazione lemmi x variabili
Facciamo ora un passo ulteriore nell’analisi. Per cogliere il modo in
cui i singoli elementi narrativi sino ad ora mostrati si trovano realmente
associati nelle singole narrazioni, abbiamo proceduto ad una analisi successiva,
la Clusters Analysis [18].
Attraverso questo iter siamo giunti ad isolare alcune tipologie o cluster
narrativi) che abbiamo chiamato “profili”.
- Profilo femminile con titolo di studio elevato.
Narrazione eroico-ascendente: sublimazione del dolore come capacità di
dominio sul non-senso e sulla superficialità dei saperi relazionali insiti
nella società; quest narratives (narrative di un viaggio per la conquista
del sé); cronicità come palestra dell’immaginario sul “bene” e sul “male”,
come conquista di una consapevolezza e di un sapere psico-relazionale
superiore;
- Profilo maschile con titolo di studio alto.
Narrazione eroico-ascendente: cronicità e andirivieni nelle crisi come
percorso di dominio progressivo della mente legato all’avvicinamento a
una verità superiore, piuttosto in chiave spirituale e di conoscenza tecno-scientifica;
- Profilo maschile con titolo di studio medio-basso.
Narrazione eroico-discendente o tragica: desiderio di restituzione al
mondo dei sani, centralità del discorso sulla farmaco-terapia, speranza
di normalizzazione funzionale, di ritorno alla funzione in senso sociale
(come riconoscimento lavorativo, come socializzazione sessuale ‘normale’
e in realtà frustrata dal continuare delle crisi);
- Profilo femminile con titolo di studio medio-basso.
Narrazione anch’essa caratterizzata in senso tragico, ma differente a
seconda che si faccia riferimento ad esperienze di ricovero adulto e legato
a crisi depressive (vi è l’idea di una «resistenza tristissima alle ingiustizie»
dice Lara e di un «tramonto delle forze») o di ricovero giovanile e crisi
dissociative (compare l’idea di colpa e di punizione, vi è un maggiore
caos narrativo e un ripetuto ricorso all’idea di perdita di sé come processo
inarrestabile).
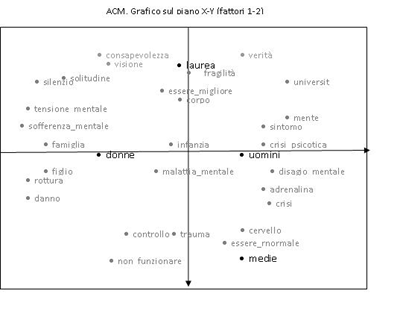 Grafico
1 ACM, fattori 1-2, 3-2 sul piano x-y
Grafico
1 ACM, fattori 1-2, 3-2 sul piano x-y
CLUSTER 1. QUEST-NARRATIVES E SUBLIMAZIONE AL FEMMINILE. CERCARE IL SENSO
DELLA SOFFERENZA NELLE RELAZIONI UMANE «PRIMARIE» («quelle che arrivano
per prime», dice una testimone) VIVENDO LUCIDAMENTE «LA RADICE PROFONDAMENTE
AMBIVALENTE DELLE RELAZIONI»
Donne con titolo di studio elevato. Maria, Maia, Margherita.
Queste narrazioni sono le testimonianze più tipicamente caratterizzabili
in termini di saga eroica progressiva o ascendente: le crisi si ripetono
e la malattia è un lungo percorso tra cadute e ri-ascese (tipiche del
profilo dell’eroe), e l’oggetto di valore (ciò a cui si tende, ciò che
addomestica la sventura e la piega ad avere senso) viene apertamente argomentato
nella forma dello «stare meglio nello stare male, nel male che gli uomini
si fanno, che va capito e accettato, qualcuno per tutti» (sempre da Margherita).
Il miglioramento è quindi inteso come capacità di comprensione delle relazioni,
di auto-addomesticamento ad esse e di scelta. Vi è chiaramente un percorso
di maturazione nel malessere legato alla capacità di dominarlo simbolicamente,
di farne qualcosa di vivo e di utile per vedere e denunciare. In tal senso,
il dominio del malessere non può essere farmacologico e individuale, ma
deve essere interpersonale e psico-analitico (riferimento forte alla parola-terapia)
così come interpersonali e di matrice interattiva sono le cause e i processi
che hanno condotto alla malattia (qui più specificamente chiamata «sofferenza»).
La propria connotazione è quindi nei termini di “resistenti al non-senso”
e di resistenti al senso attribuito da altri alla propria sventura (si
ambisce ad esprimersi per dare un contributo al sistema delle relazioni).
Ciò che ha fatto ammalare queste donne, ai loro occhi, sta anche in loro,
nell’incontro tra la loro particolarità (corpi fragili, sensibilità particolari,
sviluppi troppo veloci) e il mondo che le circonda. Il mondo maschile,
innanzitutto (ma più precisamente il maschile che c’è nel mondo e che
spesso si abbatte su una donna attraverso le altre donne). Sono storie
di donne molto esigenti con se stesse, che hanno affrontato la maternità,
il lavoro, la performance, la bellezza in un momento storico in cui tutte
queste cose venivano a cumularsi senza essere ripensate nel loro insieme,
o meglio in cui le richieste venivano a cumularsi «senza essere messe
in ordine di priorità». Ma soprattutto senza che questo ordine trovasse
nuovi referenti con i quali essere costruito: appaiono figure maschili
mute davanti al travaglio femminile, prive di parola, letteralmente (è
la prima generazione a cui il proprio matrimonio appare come «non-relazione
travestita», come dice Maria). Ma vi è anche l’emblematica presenza di
figure femminili che si affollano intorno mandando segnali contrastanti
sulla buona femminilità, estromettendosi a vicenda dal cuore della bambina,
frustrandone il bisogno di chiarezza e di sincerità (pensiamo alla lotta
tra le nonne e la madre di Margherita, al loro non essere chiare su quanto
e cosa dovrebbe fare una donna, al loro silenzio e alle loro contraddizioni
che preludono - secondo Margherita e Maia - alla dissociazione). In questi
racconti vi è l’inedita pressione performativa di contesti socio-culturali
in trasformazione che appaiono irrisolti: il passaggio da una borghesia
agricola a una borghesia professionale di città; il passaggio da un uomo
dichiaratamente autoritario a un uomo che esercita l’autorità in maniera
indiretta ma radicale, attraverso disimpegni e assenze ritenute nuova
normalità, percepite come silenzi senza appello.
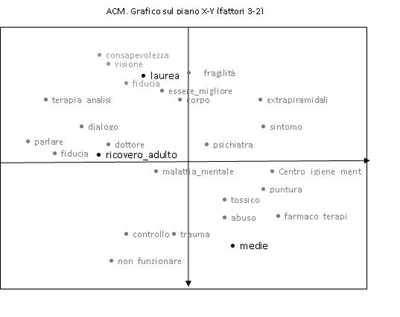 Grafico
2 ACM, fattori 1-2, 3-2 sul piano x-y
Grafico
2 ACM, fattori 1-2, 3-2 sul piano x-y
Il meglio essere (la maggior salute mentale) non è qui in riferimento
all’essere normo-dotate (il mondo normale sfugge qui alla descrizione)
ma all’essere capaci di sapere, di verità, in modo simile a quanto vedremo
nel Cluster maschile di coloro che hanno studiato e che sono stati psichiatrizzati
da adulti. In questo caso, tuttavia, si tratta della verità sulle (proprie)
relazioni e sugli scambi connotati dall’affetto, e non di verità più generali
sul mondo, come nel caso maschile.
Maia ad esempio racconta:
«Riguardo ai miei precoci atteggiamenti depressivi, ricordo che quando
ero bambina ogni tanto succedeva che tra mamma e figlia ci arrabbiassimo,
ma nel momento in cui c’era tensione e baruffa fra me e lei mia mamma
mi chiedeva di andare a darle un bacino e allora io quali alternative
avevo? La richiesta del bacio per me poteva significare due cose: che
la mamma aveva bisogno di essere rassicurata, oppure che lei era una buona
mamma e che io non ero arrabbiata con lei. Il problema era che io in quel
momento ero ar-rabbiata con lei e allora cosa potevo fare? Darle il bacino
era falso perché in quel momento avrei fatto qualunque cosa tranne quella
perché ero incavolata, ma negare un bacino alla mamma che me lo chiede
voleva dire essere cattiva, e io non volevo neanche essere cattiva, per
cui non avevo nessuna possibilità di fare una cosa che mi sembrasse giusta.
E allora qual era la soluzione che mi davo io? Sono sbagliata, sarebbe
meglio che sparissi dalla faccia della terra perché non voglio essere
né cattiva né falsa e questo è un ragionamento da depressi doc, secondo
me, perché non ci si può accollare il delitto di esistere e non si riesce
a guardare gli altri con occhio critico. Anche mia sorella si arrabbiava
con mia mamma, ma reagiva in un altro modo. Dire: io non sono come dovrei
essere perciò è meglio che sparisca, è proprio secondo me abbastanza caratteristico
di questo tipo di sofferenza mentale».
In questa sorta di quest narratives, potremmo parlare di sublimazione
della sofferenza psichica intesa come un travaglio simbolico per dare
cittadinanza al “negativo” insito nelle relazioni umane.
Susan Sontag - parlando delle metafore e più in generale delle narrazioni
collettive sulla follia nell’epoca contemporanea - ipotizza che quest’ultima
abbia ereditato le rappresentazioni con cui nell’800 si trattava la tubercolosi
(malattia che svolgeva una simile funzione di contenimento simbolico di
coloro che non riuscivano a stare al passo con la vitalità-velocità dei
nuovi tempi e del capitalismo nascente). La Sontag parla di «rappresentazioni
romantiche» in merito a queste due forme di malattia, follia e tubercolosi:
condizioni «repellenti e tormentose che diventano indice di sensibilità
superiore e veicolo di sentimenti spirituali e di malcontento critico»
(1979, p. 35) [19]. In tal senso, lei
dice, sono in realtà presentate come persone isolate e repellenti nel
loro «sperpero di vitalità non indirizzabile all’investimento» su di sé
e sulle cose, all’accumulo, al lavoro e al consumo (la Sontag parla espressamente
di contrarietà dell’homo economicus). La stessa comunità capirebbe la
natura sociale di questa emarginazione, la natura morale sottese a queste
categorizzazioni della malattia, e reagirebbe culturalmente facendone
nel pensiero comune (e soprattutto nel pensiero comune dei ceti più elevati)
forme idealizzate di resistenza spirituale ai tempi.
Rispetto alle nostre testimonianze, pur trovando una certa concordanza
nell’interpretazione della Sontag, noto qualcosa di diverso: queste donne
non presentano un’immagine di sé esterna alle brutture dell’ambiente che
le circonda, non si pongono come natura diversa rispetto alla natura dei
tempi. Non fanno astrazione romantica di sé, quanto piuttosto compartecipano
al negativo (raccontano di desiderare cose sbagliate, di essere state
bambine ultra esigenti, di avere impulsi violenti, eccetera). Insomma
è l’idea di essere immerse come gli altri in una matrice di relazioni
violente che viene solitamente negata e che per questo diviene soffocante.
L’accento è qui sulla volontà di capire: ciò che si può arrivare a vedere
è orribile ma in nome di ciò che si vede nuovamente si accede a una forma
di libertà, a una forma di vita liberata e per questo più generosa (penso
ai brani di Margherita o di Maia sul perdono dei propri genitori, ad esempio).
In ogni caso, questo soggetto narrante si carica del peso di dare senso
al male a cui lui stesso partecipa e lo colloca nel cuore delle relazioni
affettive più vere (tra sé e i propri figli ad esempio) perché si possa
parlare “veramente” di vita buona. È un soggetto ultra esigente il cui
principale nemico è se stesso, che raramente si lascia andare a “racconti
contro” (il tal medico o il tal parente, ad esempio). Se parla male dei
medici è sempre in generale, in termini astratti di medicina. In tal senso,
sono donne critiche ma anche molto disciplinate. Lo psichiatra è interiorizzato,
e la propria emancipazione dalla medicina si compie con la piena partecipazione
ai suoi criteri dello studio di sé e dell’analisi, secondo appunto categorie
psicopatologiche.
La dimensione eroico-ascendente è una dimensione che in queste narrazioni
pare essere più diffusa rispetto ad altre indagini su forme così severe
di malattia mentale (già citato nelle note: Cardano). In tal senso, come
emerge specificamente dalle parole di queste donne, Trieste si mostra
come contesto particolare di scambio, come luogo in cui i centri territoriali
paiono essere giudicati positivamente (nell’insieme) e nel quale la parola
del malato pare occupare un posto relativamente importante nell’approccio
istituzionale alla sofferenza. E tuttavia, questa percezione pare significativamente
legata al ceto della persona sofferente (si veda il cluster delle donne
con titolo di studio più basso).
CLUSTER 2. QUEST-NARRATIVES AL MASCHILE. LA TENSIONE TRA VERITA’ E VIVIBILITA’.
LA «CONOSCENZA PESANTE» COME DOVERE.
Uomini con titolo di studio elevato. Luca, Alberto.
Il discorso complessivo sulla sofferenza mentale in alcune esperienze
maschili prende una forma simile al caso precedente eppure con qualche
differenza.
Il caso di Luca ci permette di entrare nel discorso. La sua storia incomincia
con la narrazione di un andirivieni tra luoghi (Londra-Trieste, Trieste-Londra)
che sarà poi centrale nella trama narrativa. Luca viaggia, studia, lavora,
ma non trova un posto dove collocarsi nonostante lo sforzo. Il senso del
suo “movimento” non si chiarisce nel tempo e, anzi, proprio quando la
sua mente gli pare funzionare a pieno ritmo («Ero al massimo in quel
periodo, facevo benissimo matematica, avevo imparato l’inglese»),
le disconferme rispetto alla sua capacità di capire e di collocarsi aumentano,
aumenta lo spaesamento e la sensazione di non saper interpretare la complessità
del mondo circostante («Sentivo che tutto capitava per caso ma che
il caso a Londra era impossibile. Il caso era perfetto e casuale», «Non
capivo se lei voleva e non voleva e magari tutte e due le cose», «Più
io parlavo inglese più l’inglese si complicava davanti a me» ecc.).
E’ la narrazione di una crescente consapevolezza sulla complessità del
mondo e sulla propria incapacità di «leggere i giusti collegamenti» che
introduce la crisi dissociativa (intesa proprio come sottrazione al modo
comune di pensare nel tentativo di cogliere meglio i significati, le trame
invisibili). Il «muoversi delle nuvole proprio alla stessa velocità
della musica», il trovarsi di una persona in un dato luogo, le mille notizie
sui giornali e la relazione tra esse, tutto rientra per Luca in uno sforzo
accresciuto di «ragionarci continuamente su», di ragionare senza
però riuscire a sciogliere il dubbio, a collocare la propria intelligenza.
Luca racconta molto a lungo ad esempio degli atteggiamenti della ragazza
che desidera, complessi e oscillanti oltre misura, ecc.
Questo modo di narrare la schizofrenia tematizza un conflitto individuo-società:
un uomo che si ritrova costretto in prestazioni sociali senza più elevate
poter sentire questo mondo come patria, estraneo al mondo reale nonostante
tenti ragionevolmente di entrarvi, respinto in un mondo totalmente privato
che l’oggettività non riesce a scalfire. Luca, in modo contrario rispetto
alle narrazioni femminili, si pone come testimone dei suoi tempi, dai
quali prende le distanze per «eccesso di zelo». L’esperienza
del malessere mentale è quindi narrata come pensiero super-presente a
se stesso, super-potente «tanto da deformare la mente» (l’accezione di
follia come sforzo di iper-collegamento, di ultra-comprensione della realtà
circostante). I primi sintomi della crisi disso-ciativa (quel pomeriggio
in cui Luca vede per la prima volta le nuvole muoversi con i suoi pensieri)
sono letti come conseguenza di questa capacità superlogica, l’esplosione
della crisi è l’esplosione della ragione che si è troppo impegnata (negli
studi, nei viaggi, eccetera).
In quel momento, il soggetto avverte un universo che non domina, un universo
che diviene una verità pericolosa, spesso apocalittica. È sommerso dalla
paura per le verità (le nuove connessioni tra i frammenti del reale),
eppure resta nel mondo, ne sente coscienza e dai racconti pare che tale
coscienza resti sempre presente (l’impressione che «ci sia sempre
anche la realtà di prima»). Il richiamo a una nuova comprensione
non è più, quindi, alle relazioni di prossimità - come nel caso delle
narrazioni femminili prima presentate - ma al mondo, alla verità sui sistemi
di potere o, come nel caso di Alberto, su «Dio che torna ad essere visibile».
L’uomo e la sua limitata capacità di «portare il vero» sono il peso schiacciante,
la matrice della sofferenza.
In tal senso, anche la narrazione di Alberto è esemplare. Per lui stare
nel mondo «è una prova», finalizzata a raccogliere le tracce
del creatore tramite strumenti nuovi e diversi (per esempio, l’auto-ipnosi).
Il delirio mistico appare come problema non di natura qualitativa ma quantitativa
(«non devo esagerare ma voglio vedere»). Per tornare alla rappresentazione
della malattia come conflitto, qui riaffiora un sistema di asserzioni
che potremmo definire come “orizzonte magico”. Alberto ci mostra che la
religione può essere considerata oggetto di credenza delirante nella misura
in cui la cultura del gruppo non permette più di assimilare le credenze
religiose o mistiche ai contenuti della propria quotidiana esperienza.
A questo conflitto e all’esigenza di superarlo appartengono le esperienze
allucinatorie che restaurano nell’universo della follia quell’unità fortemente
ambita (quella tensione tra verità e quotidianità), che si percepisce
come lacerata. Qui è più centrale rispetto alle donne la questione della
propria collocazione, l’idea di essere inciampati proprio perché si voleva
contribuire, trovare lo spazio di azione, «avere la propria occasione
nel mondo del lavoro». E qui entra più forte la riflessione sugli altri
uomini: come dice Luca «per me ha senso raccontare la verità come
un piccolo uomo che vede le cose più amplificate rispetto a un altro più
posato».
CLUSTER 3. LA VISIONE TRAGICA: LA SVENTURA COME DESTINO E LA REMISSIVITA’
COME COLPA.
Donne con titolo studio basso e psichiatrizzazione in età giovanile. Elisabetta,
Sara, Lara, Caterina.
Vi è poi un terzo gruppo di narrazioni molto differenti da quelle precedentemente
viste, quelle delle donne con titolo di studio basso e ricovero in età
precoce. Anche in questo caso la propria malattia pare destinata a durare
(non ci si proietta nella guarigione intesa come scomparsa della sofferenza
e delle crisi) ma la resistenza a questo continuo ripresentarsi del dolore
appare stanca, stentata, maggiormente destinata alla resa. La rappresentazione
complessiva è quella di un percorso caratterizzato da brevi pause di maggior
benessere e ricadute dovute non solo alla malattia ma a nuove sciagure
esterne (la forma narrativa è quella di una catena di lutti, di incontri
con uomini violenti ad esempio, ivi comprese le figure della cura e gli
psichiatri), alle quali la testimone cerca di reagire e, reagendo, sbaglia
(«una storia dove per sfuggire ci si ficca nei guai da sole e si va
nel torto, insomma»). In tal senso, queste sono le narrazioni più
tragiche, intese tecnicamente come narrazioni di una spesa inutile di
forze da parte di chi narra. Vi è certo una maggiore idea di “cause esterne”
(di traumi alla base della malattia, legati all’ambiente familiare, ai
contatti traumatici con l’esterno), spesso leggibili in chiave di contrapposizione
tra dominio maschile violento e difficile collocazione di un soggetto
femminile (che fugge, che esce di casa, che gestisce la propria sessualità
in maniera eccessiva). La malattia è conseguenza di una violenza rifuggita,
di sventure rifiutate alle quali sono seguiti errori e altre sventure.
Il cammino si è fatto pesante e spesso domina la narrazione di una “chiusura”
e di una “rinuncia” (di un «graduale calare delle forze» vitali). La persona
si sente esposta al male - inteso prevalentemente in chiave sociale, ma
anche in chiave di sventura casuale come lo è la morte accidentale e prematura
dei cari - che mette le radici in forma di malattia, e in tal senso l’allocazione
delle responsabilità è prevalentemente all’esterno (la violenza è narrata
più chiaramente come esito della contrapposizione tra gruppi, generi,
ceti sociali, e il soggetto ne è maggiormente vittima). Queste donne sentono
uno stigma forte ma non trovano luoghi buoni per rifugiarsi. Considerano
più spesso la psichiatria come fallimento (la non guarigione) e come spazio
della violenza (intesa come «prove fallite», dei «medicinali
inadeguati» ma anche «chiusura alla comunicazione»).
Eppure, la tragicità di questi lunghi percorsi di malattia sta proprio
nel fatto di non trovare le forme di emancipazione alla quale invece pensano
di dover ambire (sono molto numerosi i richiami alla propria debolezza
nello scegliere male gli uomini, ad esempio). In tal senso sono narrazioni
in cui le donne sentono la malattia come ingiustizia, come causa esogena
e come «colpo assestato dall’esterno», ma si colpevolizzano per
il modo poco disciplinato e poco vitale, poco auto-imprenditoriale con
il quale hanno affrontato tale destino (per tornare al tema culturale
del soggetto e della sua incapacità di muoversi rispondendo alle pressioni
ad una “buona performance”).
Nella vita raccontata da Sara la morte ritorna, la violenza ritorna. La
malattia segue le sventure, è sventura tra le altre:
«E allora è così, io dovrò sempre subire. Sono schedata perché le
depressioni, gli attacchi di panico, le ansie ce li hanno i grandi signori,
gli attori, la gente bene. Loro non sono pazzi, sei tu che non sei niente
ad essere considerato pazzo, gravemente malato, e altre parole molto più
grosse di così.» (Sara).
Nel racconto di Sara sono molti i passaggi circa la scomparsa del padre
come «fine della realtà accettabile», e la sua vita appare come
«perpetuarsi di questa delusione». Il conflitto che fa da sfondo
alla narrazione pare porsi tra gli adulti e lei bambina: racconta del
suo radicamento in un sogno di infanzia interrotto, al quale subentra
la vita adulta (o meglio la vita adulta al femminile) come esposizione
alla brutalità senza protezioni. Effettivamente, il titolo di studio relativamente
basso e l’appartenenza a famiglie numerose e più problematiche sembrano
aumentare questo senso di abbandono nel male, questo salto incolmabile
tra il «rifugio agognato» e il mare aperto nel quale ci si sente.
Eppure, è una condizione dalla quale si denunciano più chiaramente le
dimensioni dei conflitti nelle quali le donne vivono immerse: la violenza
e il ricatto maschile in relazioni in cui si dipende economicamente dall’altro,
la solitudine delle proprie madri, la violenza esercitata dallo psichiatra-uomo,
eccetera.
Anche Caterina rientra, come Elisabetta ed Eleonora, in questo Cluster
(gruppo) di narrazioni. La sua testimonianza è particolarmente interessante
per quello che riguarda il discorso sulla psichiatria, per la quale lei
è giunta «a provare nel tempo una vera avversione». In lei è
centrale la questione dei farmaci, di quello che percepisce come inganno
di una cura che non è affatto certa, che le appare infine casuale, a tentativi,
fonte di sofferenze aggiuntive, troppo grandi appunto perché «taciute,
non spiegate mai prima» (parla molto delle controindicazioni dei
farmaci ad esempio). Queste sono narrazioni in cui vi è molto più spazio
per i passaggi tra diversi centri e diversi psichiatri, sulla mancanza
di continuità e coordinamento tra strutture, sull’idea di una scienza
«disordinata, legata al caso» e colpevole di troppo sbagliare
senza dirlo.
CLUSTER 4. LA RESTITUZIONE AL MONDO DEI NORMALI E IL DESIDERIO FRUSTRATO
DI UNA DEGNA FUNZIONE. «L’ODIOSA NATURA DEL MALATO» E L’IMPRODUTTIVITA’
COME COLPA.
LE POTENTI NEUROSCIENZE E LE TRAGICHE DISILLUSIONI.
Uomini con titolo studio basso e psichiatrizzazione in età giovanile.
Roberto, Carlo, Davide, Fabio.
Quest’ultimo tipo di narrazioni è quello più marcatamente caratterizzato
da una visione della malattia come «disfunzione organica». L’allocazione
delle responsabilità è solitamente legata a nozioni che potremmo definire
di importazione dal linguaggio neuro-scientifico. Il cervello, la mente
e le sue esplosioni, l’adrenalina e i flussi ormonali sono concetti che
servono a narrare una «personalità in balia del corpo». Al centro
delle narrazioni vi è il tentativo di riappropriarsene grazie alla farmacologia.
In maniera abbastanza evidente, dunque, potremmo qui parlare di aspirazione
«normalità», concetto qui molto più presente, intesa come collocazione
nel mondo dei lavoratori, delle persone autosufficienti dal punto di vista
economico, e sopratutto «competenti», capaci di specifica funzione (nel
racconto di Carlo vi è una ridondanza particolare sulle doti tecniche
da cuoco ad esempio).
In tal senso, il punto di vista della società esterna sembra essere acquisito,gli
altri utenti del servizio psichiatrico appaiono agli occhi di questi testimoni
come persone piuttosto «false» o «fannulloni», e i riferimenti all’amicizia
sono essenzialmente diretti agli infermieri, citati molto più che nelle
altre narrazioni. Il malato mentale è un dis-adatto che cerca di adattarsi
e rimprovera chi non si adatta. Le riflessioni sulle proprie relazioni
di prossimità sono molto meno importanti rispetto alle narrazioni precedenti,
mentre prendono grande spazio le riflessioni sul lavoro e sulla quotidianità
interrotta. Il tal senso, questo soggetto si concepisce nei termini di
ego fungens, vale a dire trae legittimazione dalla propria funzione sociale
codificata in forma di lavoro salariato (a cui viene associata sempre,
ad esempio, la possibilità di avere le donne), e trae senso di colpa dal
non riuscire a svolgerlo. In questo caso, la collocazione esterna delle
cause (di tipo organico) e della responsabilità rispetto alla malattia
pare agire come fuga dal peso dell’improduttività, come dispositivo di
discolpa. La medicina pare svolgere il ruolo di contenere questo tipo
di disperazione, di cogliere il desiderio di tornare tra gli altri e come
prima (emblematico il fastidio ricorrente per i propri compagni di sventura
che non prendono le medicine). La pressione verso la “funzione produttiva”
pare qui socialmente e culturalmente molto forte, come era forse comprensibile
per uomini di ceto medio-basso.
Infine, la medicina, in queste narrazioni, è massimamente responsabilizzata
nei termini di normalizzazione (corporea e perciò - poi - sociale). Il
fatto di essere entrati in contatto in giovane età con le strutture psichiatriche
e di averne girate molte non sembra qui di per sé negativo, come invece
nel caso precedente delle donne, poiché appunto ci si affida al farmaco
più che allo psichiatra. E tuttavia la disillusione verso la “mancata
guarigione” è a tratti molto forte e molto cocente.
Infine, le forme espressive della sofferenza mentale di cui rendiamo conto
contengono al loro interno coordinate socio-culturali (grandi temi culturali)
rispetto ai quali la nostra epoca ‘stressa’ i soggetti e li scuote diversamente
a seconda della collocazione biografica (il genere ecc.), sociale (il
titolo di studio ecc.). Nel caso delle nostre narrazioni, possiamo individuare
l’evocazione trasversale di alcune “forze agenti”:
la relazione di coppia e la questione di una emancipazione femminile sospesa
e ambivalente;
la “funzione sociale” dell’individuo in un’epoca di mutamento dei sistemi
produttivi (la precarietà dell’operaio e la difficile prestazione maschile);
la “performanza sociale” (la prestanza) percepita come obbligatoria nei
contesti di investimento sulla formazione dei singoli ma impossibile poi
nel mondo fattosi vasto («quanta gente brava c’era a Londra!» dice Luca);
il conflitto tra linguaggi dell’istituzione psichiatrica (a volte coercitivi)
e quelli emergenti del diritto individuale del malato, dell’informazione,
della scelta terapeutica;
la promessa di guarigione insita nel farmaco e la disillusione che ne
deriva.
Queste questioni appaiono in maniera trasversale e fanno da sfondo a tutte
le narrazioni sulla sofferenza, ma risultano diversamente significate
e diversamente associate tra loro dai testimoni a seconda della loro formazione
e del loro iter psichiatrico, mettendo in evidenza diverse strategie di
(auto) controllo e di (auto) medicalizzazione.
Note
1] Paradossalmente, il problema
degli utenti psichiatrici di lunga data è che loro hanno masticato tantissima
“narrazione” proprio poiché le parole sono state a lungo gli unici strumenti
professionali che la medicina psichiatrica potesse usare per “definire”
il problema, tanto nei termini di “cause” quanto nei termini di “sintomi”,
al contrario di quasi tutte le altre discipline mediche centrate sulla
osservazione “strumentalizzata” del corpo. Questo costituisce appunto
una delle differenze ontologiche della psichiatria (sebbene oggi le neuroscienze,
il brain imaging ecc. ambiscano nei fatti a ridurre tale differenza).
2] Fabietti U. (a cura di) (1998),
Etnografia e culture. Antropologi, informatori e politiche dell’identità,
Carocci, Roma.
3] “Campionamento ragionato” e
“corretto” sono espressioni in parte improprie nel nostro caso, così caratterizzato
dalla disponibilità o meno delle persone a partecipare che ha operato
certamente una “autoselezione” del campione. Tuttavia tali espressioni
sono consentite dall’dea di controllo operato su variabili significative
come genere e titolo di studio (fare in modo che vi fossero tanti uomini
quante donne, tanti laureati quante persone con il diploma di terza media,
ecc.).
4] Non mi dilungherò sugli aspetti
metodologici che caratterizzano le indagini qualitative “ancorate” ai
dati - “grounded” appunto -, sul criterio di abduttività (circolarità
tra ipotesi e informazioni raccolte) e sui procedimenti di saturazione
delle ipotesi nel corso dell’indagine. Per la definizione di questi concetti
rimando a Silverman D. (2002), Come fare ricerca qualitativa. Una guida
pratica, Carocci, Roma, dove questi riferimenti teorici sono chiaramente
esposti, come d’altra parte in molti altri testi sulla ricerca qualitativa.
5] Sull’idea dell’intervista come
“con-testo”, vale a dire come situazione (potremmo dire quasi “setting”)
all’interno del quale si stabiliscono gradualmente, per adattamento reciproco,
i contenuti e le “narrazioni condivisibili”, rimando in particolare modo
all’interessante approccio di Lutter nella presentazione dei così detti
“cultural studies” in Lutter C., Reisenleitner M. (2004), Cultural Studies,
Un’introduzione (versione italiana a cura di M. Cometa), B. Mondadori,
Milano.
6] Rimando al saggio “E’ mia la
tua follia” contenuto nell’opera Come stai in famiglia, a cura di Alessandro
Bosi (2008), Battei editore, Parma, ho condotto un’analisi più puntuale
della conversazione tra me e i miei intervistati (anch’essi nell’ambito
di una indagine sui servizi psichiatrici visti dagli utenti), soffermandomi
più specificamente sulle modalità con cui veniva indirizzata la narrazione
al di là delle domande esplicite (incoraggiamenti, battute, soste, chiarimenti
ecc.).
7] Per comprendere meglio la relazione
tra malattia, narrazione biografica e rielaborazione dei punti di rottura
o di discontinuità esistenziale, rimando certo a Bonica L., Cardano M.
(a cura di) (2008), Punti di svolta. Analisi del mutamento biografico,
Il Mulino, e in particolare a Il male mentale. Distruzione e ricostruzione
del sé di Cardano, ma anche più specificamente rispetto alle illness narratives,
ai vecchi lavori di Bury, Frank, Good e altri, numerosi già a partire
dagli anni ’80: Bury, 1982, Chronical illness as biographical disruption,
in Sociology of Health and Illness, 4, 167-82.; Frank, A.W. (1993) The
rhetoric of self-change: illness experience as narrative. The Sociological
Quarterly, 34, 39-52; Frank, A.W. (1994) Reclaiming an orphan genre: the
first-person narrative of illness. Literature and Medicine, 13, 1-21;
(vers, it.) Good J. B. (1999), Narrare la malattia, Edizioni Comunità,
ecc.
8] Si veda Greimas (1998) citato
da Cardano M. (2007), «E poi cominciai a sentire le voci...». Narrazioni
del male mentale, in Rassegna Italiana di Sociologia, anno XLVIII, num.1,
pp. 9-56.
9] Si veda Frank, A.W. (1995)
The Wounded Storyteller. Body, Illness, and Ethics. Chicago University
Press, e saggi successivi.
10] Ci si può rifare ai primi
schemi degli anni ’90, si pensi a Twattel (1994) Disease, Illness and
Sickness: Three Central Concept in the Theory of Health, in Studies in
Health and Society, n. 18 pp.1-18, ma anche alle più recenti elaborazioni
dei diversi “domini semantici” che illuminano gli universi di significato
del concetto stesso di “malattia” come in Cipolla C., Maturo A. (2009),
a cura di, Con gli occhi del paziente. Una ricerca nazionale sui vissuti
di cura dei pazienti oncologici, Franco Angeli, Milano ecc.
11] È importante sottolineare,
anche se va da sé per chi si occupa di “narrazioni”, che ai nostri occhi
si è sempre trattato di pratiche discorsive che non arrivano a definire
fatti (passati e presenti) o condizioni oggettive (passate e presenti).
Si tratta di espressioni negoziali, di ricostruzioni identitarie rivolte
all’idea di Altro (alla ricercatrice “sana di mente e magari progressista”
o alla ricercatrice “che forse cerca di capire se i medici sono stati
la mia rovina o la mia salvezza..” come mi hanno detto le mie testimoni
scherzando, ma intanto chiarendo perfettamente quello che loro consideravano
come “dispositivi interattivo” della nostra comunicazione). La narrazione
non raccoglie una traiettoria già data ma la ri-crea, come da tantissimi
autori ormai sottolineato, la rende possibile perché la espone ad uno
spazio comune (esplicita ciò che è dicibile nello spazio tra il narratore
e l’ascoltatore). E infine la narrazione in prima persona sulla sofferenza
mentale non è considerabile come narrazione “interna” (come se parlasse
l’esperienza) o “esterna” (come se ci si staccasse dal passato e si parlasse
della esperienza).
12] Rimando ad esempio a Olagnero
M. (2004) Vite nel tempo. La ricerca biografica in sociologia, Roma, Carocci.
13] Questo ambito è davvero
particolare anche perché non è da intendere solo come narrative about
illness ma anche come narrative as illness, come sottolinea bene nella
sua “ripartizione tipologica” Hyden L. C. (1997), Illness and Narrative,
in Sociology of Health Review alludendo a quelle malattie caratterizzate
proprio da una particolare predisposizione al tempo biografico. Ci tengo
a sottolineare, se pur brevemente, che con la nostra indagine non intendevamo
occuparci di questo aspetto, e che le narrazioni biografiche raccolte
non sono narrazioni “caotiche”, per citare un’altra categoria analitica.
14] Si veda Hyden, L.C.(1995)
In search of an ending. Narrative reconstruction as a moral quest, in
Journal of Narrative and Life History, 5, 67-84.
15] Queste categorie riprendono
una lunga discussione sul racconto della malattia come racconto epico,
per la quale rimando a Gergen (1994), Realities and Relationship, Cambridge,
Harvard University Press, già citato in Cardano (2007) op. cit. – e ad
una più vasta serie di autori che in realtà si rifanno a più vecchi lavori
(si veda Frye e le sue strutture narrative biografiche).
16] Uno degli aspetti maggiormente
degni di attenzione riguarda, a mio avviso, la capacità di rendere in
“metafora” la sofferenza mentale esperita attraverso altri tipi di sofferenza,
vale a dire di tradurre l’esperienza della dissociazione, piuttosto che
dell’angoscia, nel registro di altri dolori comuni o immaginati come tali.
In questi passaggi narrativi lo sforzo è quello di mettere in comune un
dolore acuto alludendo a una forma della sofferenza che si pensa vissuta
da tutti (e quindi alludendo al fatto che la sofferenza è comunemente
umana, che tutti provano condizioni di lutto, o emarginazione, o diversa-abilità,
che se richiamate possono fare luce sulla sofferenza psichica). La strategia
narrativa principalmente adottata quindi non è quella di spiegare realisticamente
i dettagli di alcune condizioni o esperienze (pur se a volte anche questo
accade e lo abbiamo visto) ma di evocare l’alfabeto condiviso della dimensione
emotiva («essere svegli nella notte mentre gli altri dormono», «parlare
una lingua sconosciuta agli altri», eccetera). Su questo rimando alla
monografia Pellegrino V. (2012), Sofferenza, caos e sublimazione nelle
parole dei pazienti psichiatrici (titolo da confermare), UTET, in uscita.
17] Ricordo qui che, in tale
analisi, u’associazione non si riferisce immediatamente alle narrazioni
nel loro insieme, ma ai tratti di narrazione, ai contesti elementari di
analisi in cui sono divise le interviste e che si riferiscono ai singoli
concetti espressi. Le parole - o meglio i “lemmi” che possono rimandare
anche a concetti (parole associate) - sono le variabili attive nell’analisi
nella modalità presenti/assenti; le caratteristiche individuali (genere,
titolo di studio, eccetera) fungono da variabili illustrative.
18] L’analisi tematica dei contesti
elementari che TLAB esegue come Analisi dei Clusters è una analisi multivariata
che consente di costruire ed esplorare una rappresentazione dei contenuti
del corpus attraverso i cluster tematici (minimo 3, massimo 50), ciascuno
dei quali: a) risulta costituito da un insieme di contesti elementari
(frasi, paragrafi o testi brevi quali risposte a domande aperte) caratterizzati
dagli stessi pattern di parole chiave; b) è descritto attraverso le unità
lessicali (parole, lemmi o categorie) e le variabili (se presenti) che
piú caratterizzano i contesti elementari da cui è composto. Per molti
versi, si può affermare che il risultato dell’analisi propone una mappatura
delle isotopie (iso = uguale; topoi = luoghi) intese come temi “generali”
o “specifici” caratterizzati dalla co-occorrenza di tratti semantici (si
veda Rastier, 2002 in Lancia (2004), Strumenti per l’analisi dei testi,
Franco Angeli, Milano). In tal senso la Cluster Analysis rappresenta un
passo successivo alla ACM: ogni cluster è caratterizzato da insiemi di
unità lessicali che condividono gli stessi contesti di riferimento, e
ciò consente di ricostruire “un filo” del discorso all’interno della trama
complessiva costituita dal corpus.
19] Si veda Sontag S. (1979),
Malattia come metafora. Aids e cancro, Einaudi, Torino.


 DOAJ
Content
DOAJ
Content
newsletter subscription
www.analisiqualitativa.com